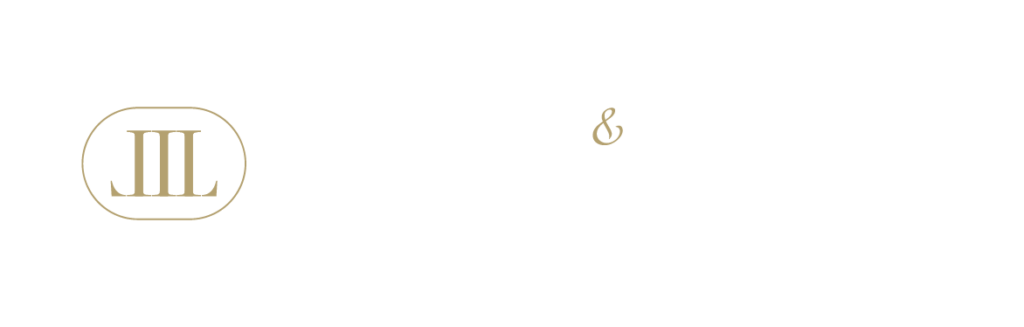Immagina di arrivare al Pronto Soccorso incosciente. I medici non sanno a quale farmaco sei allergico, di quali patologie soffri, quali medicine già assumi. Eppure tutte queste informazioni non solo esistono, ma vengono registrate automaticamente nel tuo Fascicolo Sanitario Elettronico dal 2020. Il paradosso? Sono intrappolate in un sistema che non funziona.
Il FSE era la risposta strategica a questo problema: la promessa di una sanità più sicura, efficiente e con zero sprechi. Sono trascorsi tredici anni dall’approvazione e, nonostante centinaia di milioni di euro investiti, il sistema è ancora in stallo.
Il Profilo Sanitario Sintetico – il documento salvavita che doveva essere consultabile in emergenza anche senza consenso – doveva essere operativo dal 30 settembre 2025. A ottobre 2025, solo il 5% dei medici lo ha compilato e la scadenza è slittata a dicembre.
La mancanza di un accesso rapido e completo alla storia clinica non è un mero disagio burocratico. Si traduce in diagnosi ritardate, esami duplicati inutilmente e, soprattutto, in un rischio inaccettabile per la sicurezza dei pazienti che continuano ad essere curati “al buio”.
Cos’è il Fascicolo Sanitario Elettronico e la promessa del 2012
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) non è un’invenzione recente, ma una promessa generata oltre un decennio fa con l’obiettivo di rivoluzionare l’assistenza sanitaria italiana. La sua elaborazione ufficiale risale al Decreto Legge 179/2012, che ne sanciva la nascita come strumento cardine della digitalizzazione della sanità. La visione originale era chiara e ambiziosa: raccogliere in una cartella clinica digitale unica e accessibile, l’intera storia clinica del paziente. Il FSE doveva superare l’era della carta e della frammentazione informativa.
La visione originale
I benefici attesi andavano al cuore del rapporto medico-paziente e dell’organizzazione del SSN:
- Riduzione del rischio: accesso immediato alle informazioni in emergenza, un fattore decisivo per prevenire reazioni avverse e diagnosi errate.
- Cura integrata: assicurare la continuità assistenziale tra diverse strutture, che non fosse più interrotta dai confini amministrativi.
- Efficienza organizzativa: generare un risparmio economico per il SSN grazie all’eliminazione della riduzione esami duplicati.
Il FSE era stato elaborato per divenire l’unico strumento di accesso alla totalità dei dati clinici e amministrativi di un paziente. Il contenuto previsto includeva:
- Documentazione clinica essenziale: comprensiva di tutti i referti specialistici e di laboratorio, i verbali di pronto soccorso e le lettere di dimissione ospedaliera. Questi documenti forniscono il quadro diagnostico e terapeutico di base.
- Lettere di dimissione ospedaliera, inclusiva dei documenti che riepilogano il percorso clinico durante un ricovero, la diagnosi, le terapie somministrate e le indicazioni post-dimissione. Una documentazione cruciali per la continuità assistenziale.
- Prescrizioni farmaceutiche (le cd. ricette), che consistono nell’elenco delle medicine e dei prodotti sanitari prescritti.
- Vaccinazioni, con il registro completo delle vaccinazioni effettuate, con date e tipologie. Questa documentazione è essenziale per la prevenzione e per la verifica dello stato immunitario.
- Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (il “testamento biologico”), che prevedono i trattamenti sanitari da accettare o rifiutare in caso di futura incapacità da parte del paziente di prendere decisioni.
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è stato concepito come uno strumento cruciale per la digitalizzazione della sanità italiana, ideato per raccogliere la storia clinica di ogni cittadino. Nonostante la sua istituzione risalga al 2012 e gli ingenti investimenti, il percorso è stato segnato da un’implementazione caotica, trasformandolo per molti anni in un’opportunità mancata, incapace di dispiegare il suo potenziale a causa di una profonda frammentazione regionale e una cronica sottoutilizzazione.
Frammentazione regionale e sottoutilizzazione: un sistema che non decolla
L’errore iniziale di progettazione è stato delegare l’implementazione del FSE alle singole Regioni e Province Autonome. Anziché un unico sistema nazionale, sono nati 21 sistemi diversi che, per anni, non comunicavano tra loro, generando enormi disparità territoriali tra Nord e Sud.
Il paradosso era evidente: un cittadino toscano in vacanza in Veneto, in caso di emergenza, non poteva garantire ai medici l’accesso immediato al suo FSE di origine. Ma la strada è ancora lunga: secondo la Fondazione Gimbe, solo 4 documenti su 16 sono disponibili in tutte le Regioni, con tassi di completezza che variano dal 90% in alcune aree al 50% o meno in altre.
Il doppio paradosso del consenso
Dal 2020, l’alimentazione del FSE è automatica: i dati vengono caricati senza bisogno del consenso del paziente. Sembrerebbe un passo avanti verso l’efficienza. Ma qui emerge il primo paradosso: per consultare questi dati, i medici hanno bisogno del consenso esplicito del paziente.
Questo crea scenari assurdi:
- Il paziente ignaro: molti cittadini non sanno che devono dare il consenso alla consultazione. Il loro FSE si riempie automaticamente di dati, ma nessun medico può leggerli perché manca l’autorizzazione.
- Pochi medici consultano il FSE: anche quando il consenso c’è, solo una minoranza di medici consulta regolarmente il Fascicolo. La ragione? Sistemi scomodi e, soprattutto, la consapevolezza che i dati sono spesso incompleti.
La questione dei dati storici: la storia clinica inaccessibile
L’incompletezza dei dati è il tallone d’Achille del sistema e lo rende potenzialmente inutile in emergenza. Decine di anni di cartelle cliniche cartacee, essenziali per comprendere la salute del paziente, non sono accessibili.
Di conseguenza, il FSE è spesso fuorviante. In assenza della storia clinica integrale, il personale medico corre il rischio di diagnosi errate in emergenza a causa di
Investimenti sprecati
Questi anni di inefficacia hanno portato ad uno spreco finanziario colossale: centinaia di milioni di euro sono stati versati in sistemi non comunicanti e inutilizzati. Un fallimento che ha generato profonda frustrazione sia tra i cittadini, privati di uno strumento essenziale, sia tra gli operatori sanitari, bloccati nell’innovazione.
Il caos solleva questioni legali spinose in tema di responsabilità sanitaria digitale: a chi imputare un danno subito dal paziente se il medico non ha potuto accedere a informazioni vitali, magari contenute in un FSE di un’altra Regione o in un archivio cartaceo non digitalizzato? Se l’omesso accesso ai dati è causa di danno, la responsabilità sanitaria potrebbe ricadere sull’ospedale o sull’ente regionale che non ha assicurato né l’interoperabilità né la piena operatività del Fascicolo.
FSE 2.0 e il Profilo Sanitario Sintetico: la nuova promessa già tradita
L’aggiornamento al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0) è nato con l’ambizione di sanare il male storico della sanità italiana: la frammentazione regionale. L’obiettivo era duplice:
- Uniformità nazionale: un sistema unico che superasse le disparità tra Regioni
- Interoperabilità totale: garantire che la cartella clinica digitale sia accessibile ovunque in Italia
In questo sistema, il Profilo Sanitario Sintetico (PSS) – o Patient Summary – doveva essere la vera rivoluzione. Un documento salvavita contenente:
- Allergie note e reazioni avverse
- Patologie croniche (diabete, ipertensione, ecc.)
- Terapie in corso
- Informazioni critiche (trapianti, organi mancanti)
In caso di emergenza, il PSS è l’unica sezione del FSE accessibile immediatamente ai medici, anche senza consenso esplicito del paziente. La sua disponibilità permette di agire con prontezza assoluta, evitando ritardi diagnostici e riducendo il rischio di somministrare farmaci controindicati.
Il flop del settembre 2025: scadenza mancata
La scadenza era il 30 settembre 2025. Il Ministero della Salute aveva stabilito che entro quella data il PSS doveva essere operativo su tutto il territorio nazionale, compilato e aggiornato obbligatoriamente da ogni medico di medicina generale.
La realtà a ottobre 2025:
- Solo il 5% dei medici ha compilato il PSS
- Il sistema è slittato a dicembre 2025
- I medici denunciano enormi difficoltà: sistemi informatici obsoleti, software non aggiornati, mancanza di formazione
- I pronto soccorso continuano a lavorare “al buio”
Roberto Carlo Rossi, Presidente dell’Ordine dei Medici di Milano, è stato brutalmente chiaro: “Con un sistema informatico che fa acqua da tutte le parti, l’applicazione del PSS sarà ardua se non impossibile. Tutti devono far finta che possa funzionare per rispettare i termini del PNRR, tranne chi con questo sistema deve lavorare.”
Il paradosso del consenso alla consultazione: quando la burocrazia blocca le cure
Anche con l’alimentazione automatica del FSE (introdotta nel 2020), permane un nodo critico: il consenso alla consultazione. In Italia, diversamente da molti Paesi europei che adottano un approccio opt-out, il sistema richiede un consenso esplicito del paziente affinché i medici possano leggere il suo Fascicolo.
Questo crea scenari assurdi che trasformano un diritto alla privacy in un potenziale pericolo per la salute:
Scenario 1: il paziente ignaro
La stragrande maggioranza dei cittadini non sa di dover dare il consenso alla consultazione. Il FSE si riempie automaticamente di dati (dal 2020), ma rimane inaccessibile ai medici. In caso di ricovero urgente, il medico si trova di fronte a una cartella clinica digitale piena ma “sigillata”, non per scelta consapevole del paziente, ma per ignoranza del sistema.
Secondo i dati ufficiali, meno della metà degli italiani ha dato il consenso alla consultazione del FSE. Questo significa che milioni di fascicoli esistono ma sono inutilizzabili.
Scenario 2: il paziente diffidente
Una minoranza di pazienti, per timore di violazioni della privacy, rifiuta consapevolmente il consenso. Sebbene sia un diritto legittimo, cosa succede quando questo paziente arriva incosciente in Pronto Soccorso? Il medico deve procedere “al buio”, anche se il FSE esiste ed è pieno di informazioni potenzialmente salvavita.
Scenario 3: l’emergenza e il PSS fantasma
Per ovviare a questi problemi, il FSE 2.0 aveva introdotto il Profilo Sanitario Sintetico (PSS), accessibile in emergenza anche senza consenso esplicito (consenso presunto). Una soluzione brillante sulla carta.
Il problema? A ottobre 2025 il PSS non è operativo. Anche se la legge prevede l’accesso in emergenza, se il Medico di Base non ha compilato il PSS (e solo il 5% lo ha fatto), il sistema salvavita rimane una scatola vuota. L’accesso legale è garantito, ma i dati essenziali semplicemente non esistono.
Chi risponde quando il sistema non funziona? Le zone grigie della responsabilità
L’inefficacia e la frammentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) sollevano interrogativi cruciali, uscendo dal piano tecnico per sfociare in quello legale: in caso di danno al paziente causato da informazioni mancanti o inaccessibili, chi è il soggetto responsabile? La risposta è complessa, poiché la responsabilità sanitaria digitale si divide tra medici, strutture e istituzioni, lasciando il paziente danneggiato in una difficile “zona grigia legale”.
Scenario 1: danno per mancanza di informazioni essenziali
Consideriamo un caso concreto, purtroppo verosimile: un paziente giunge in Pronto Soccorso in stato d’incoscienza o comunque non in grado di fornire dati anamnestici completi. Il medico, a causa di un FSE vuoto o un sistema non funzionante, somministra un farmaco che innesca una grave reazione allergica (ignota, ma registrata sul Fascicolo) con conseguenze permanenti.
Chi è responsabile in questo scenario?
- Il medico? Ha agito in buona fede seguendo i protocolli d’emergenza, ma aveva l’obbligo di accedere ai dati se disponibili. Se l’informazione salvavita non era consultabile, il medico non ha potuto adempiere pienamente al suo dovere di diligenza.
- La struttura ospedaliera? Ha la responsabilità di fornire strumenti informatici adeguati (Art. 12, D.L. 179/2012). Se il danno deriva da un malfunzionamento tecnico o dalla mancata integrazione del sistema, la sua colpa è chiara.
- La Regione/Stato? La responsabilità delle Regioni è elevata. Sono i titolari del trattamento dei dati per finalità di cura. Il ritardo sistemico nell’implementazione del FSE 2.0 e del Profilo Sanitario Sintetico (PSS), promesso come salva-vita, può essere visto come una colpa istituzionale per non aver garantito l’infrastruttura di sicurezza promessa.
- Il paziente? La zona più controversa. Il paziente che non ha attivato il FSE (pur essendo stato istituito d’ufficio) ha contribuito alla mancanza di dati accessibili.
È estremamente difficile dimostrare il nesso causale tra la disfunzione del sistema digitale e il danno clinico. La responsabilità è frammentata, e il paziente rischia di vedere il risarcimento negato o ridotto proprio a causa di questa diluizione delle colpe.
Scenario 2: l’ostacolo del rifiuto consapevole
Si pone un interrogativo etico-giuridico quando l’utente ha intenzionalmente rifiutato l’autorizzazione all’accesso al FSE, richiamando il diritto alla tutela dei dati sensibili (prerogativa garantita dal GDPR).
Se ne deriva un detrimento per la salute direttamente correlato all’omissione di quelle informazioni che l’assistito ha preferito non rendere consultabili, si può delineare un possibile “concorso di colpa” del paziente stesso. Tuttavia, l’ordinamento legale non può esimere interamente l’equipe sanitaria dal precetto di somministrare la cura ottimale. L’aspetto centrale da definire è: con quale lucidità il paziente aveva valutato le ripercussioni severe del suo mancato assenso in un frangente di crisi? Il rifiuto ha valore soltanto se il paziente ha ricevuto una spiegazione pienamente chiara e completa di tutte le possibili conseguenze.
Scenario 3: dati presenti, sistema in tilt
Questo è lo scenario in cui la responsabilità è meno ambigua: il FSE esiste ed è “pieno” di referti e dati, ma al momento della consultazione il sistema è in tilt, la rete è guasta o l’accesso è impossibile. In questo caso, la responsabilità della Struttura/Regione per la gestione informatica del sistema è palese. Nonostante ciò, il medico rimane comunque vincolato all’obbligo di raccogliere informazioni con mezzi alternativi (es. contatto con il Medico di Base, o con i familiari). La legge richiede la diligenza professionale: la disfunzione digitale non è una scusa assoluta per l’errore.
Attualmente, la giurisprudenza in Italia sul danno da FSE è nebulosa e scarsa. Essendo il sistema troppo nuovo, frammentato e ancora disfunzionale (soprattutto per quanto riguarda il PSS), mancano precedenti legali solidi.
La Corte di Cassazione ha chiarito, in materia di responsabilità medica, che la mancanza di una cartella clinica (o documentazione in genere) non penalizza il paziente, anzi, può rafforzare l’ipotesi di malpractice. Analogamente, la mancanza di informazioni accessibili sul FSE, anche se i dati esistono digitalmente, può contribuire in modo decisivo a errori medici evitabili, rendendo la struttura ospedaliera e la Regione i primi soggetti chiamati a rispondere per non aver garantito uno strumento fondamentale per la sicurezza della cura.
Il costo dell’inefficienza: sprechi economici e vite a rischio
L’inerzia e l’incompiutezza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) non sono solo un fallimento tecnologico o un disagio per il paziente. Sono un peso economico enorme e, soprattutto, un fattore di rischio diretto per la salute pubblica. L’assenza di una vera cartella clinica digitale unificata si traduce in sprechi economici inaccettabili e in un incalcolabile costo umano, misurato in vite a rischio.
Il costo più tangibile e frustrante dell’inefficienza ricade direttamente sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e sul paziente: la duplicazione degli esami.
Quando un medico, specie in un nuovo ospedale o in una diversa Regione, non ha accesso immediato e certo alla storia clinica (perché il FSE è vuoto o l’interoperabilità fallisce), il protocollo di sicurezza impone di ordinare nuovamente esami diagnostici già eseguiti.
- Costo per il SSN: Ogni esame di laboratorio, ogni radiografia e ogni TAC duplicata rappresenta uno spreco economico diretto di denaro pubblico, risorse tecniche e tempo del personale. In un sistema sanitario sotto pressione finanziaria, questo è inammissibile.
- Disagio per i pazienti: I cittadini sono sottoposti inutilmente a nuove procedure, esami invasivi o a ulteriori dosi di radiazioni, generando frustrazione come paziente e ritardi nelle cure che dovrebbero essere immediate.
In un contesto di emergenza, l’assenza di dati accessibili smette di essere solo un problema economico e diventa un problema etico-legale.
- Ogni minuto conta: nei Pronto Soccorso, il tempo è una risorsa critica. Invece di concentrarsi sulla cura immediata, i medici sono costretti a trasformarsi in “investigatori”: telefonate tra strutture sanitarie, ricerche manuali di referti cartacei o tentativi di contattare i familiari. Questa situazione si inserisce in un contesto più ampio di crisi del sistema sanitario, dove gli operatori lavorano già in condizioni di stress estremo.
- Aumento del rischio: il tempo sprecato si traduce in ritardi diagnostici evitabili. La fretta, unita alla mancanza di informazioni complete (come le allergie vitali che il PSS dovrebbe fornire), moltiplica il rischio di errori medici.
- Il FSE come garanzia legale: un sistema pienamente funzionante e compilato sarebbe la prima linea di difesa per il medico, fornendo la prova della diligenza professionale (aveva i dati per decidere) e riducendo il rischio di responsabilità sanitaria digitale derivante da omissioni informative.
L’incompiutezza del FSE 2.0 e del PSS non è solo una cifra mancata nel bilancio, ma il riflesso di un sistema che, nei momenti più critici, non è in grado di proteggere al meglio i suoi cittadini.
Lezioni dall’Europa: come altri paesi hanno risolto il problema
Mentre in Italia il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) si dibatte tra ritardi e il paradosso del consenso, altri paesi europei hanno già completato la loro digitalizzazione della sanità, dimostrando che un sistema unificato e sicuro non è un miraggio. Il confronto è impietoso e serve a evidenziare come l’Italia possa (e debba) fare meglio.
Regno Unito: il modello opt-out che funziona
Il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) nel Regno Unito ha adottato un approccio pragmatico: il sistema è attivo per default (modello opt-out) per tutti i cittadini. La privacy è tutelata, ma con una prospettiva diversa: il cittadino può rifiutare esplicitamente l’adesione se lo desidera.
Il risultato? Un tasso di adesione vicino al 100%, che garantisce accesso immediato alle informazioni in ogni circostanza. I medici in emergenza non devono interrogarsi sull’esistenza della cartella clinica digitale del paziente, riducendo drasticamente errori medici e ritardi diagnostici.
Estonia: l’obbligo di legge per la sicurezza
Il sistema estone si basa su un obbligo stabilito per legge: l’istituzione e l’utilizzo della cartella clinica digitale sono obbligatori. Grazie a un’integrazione completa tra tutte le componenti sanitarie, i medici beneficiano di una consultazione immediata dell’intera storia clinica.
La privacy non viene compromessa, anzi: è rafforzata da una tracciabilità totale. Ogni accesso al fascicolo viene registrato e il paziente può verificare chi ha consultato i suoi dati. Un sistema che al momento della sua introduzione è stato salutato con scetticismo ma che oggi è considerato il sistema sanitario digitale più avanzato al mondo.
Germania: opt-in con informazione capillare
Il caso tedesco è particolarmente significativo. Nonostante adotti un sistema di adesione volontaria (opt-in) analogo a quello italiano, ha investito massicciamente in campagne di sensibilizzazione nazionali capillari.
Il loro approccio è chiaro: per garantire il successo della digitalizzazione sanitaria, bisogna andare oltre la tecnologia. Serve superare la diffidenza sul consenso con informazioni trasparenti, trasformando il FSE in una risorsa attivamente ricercata e compresa dall’utenza.
I modelli europei di successo poggiano su due pilastri fondamentali:
- Comunicazione chiara (come in Germania), che trasforma il cittadino confuso in un utente informato e attivo.
- Unificazione totale (come in Estonia e nel Regno Unito), che evita la frammentazione regionale creando piattaforme nazionali interoperabili.
L’esperienza estera dimostra che l’Italia, per superare i problemi di responsabilità e le informazioni mancanti, deve fare una scelta netta: abbandonare l’attuale burocrazia del consenso alla consultazione a favore di uno standard operativo unico che privilegi la disponibilità dei dati clinici come tutela primaria per la vita del paziente.
Il Fascicolo Sanitario Elettronico doveva essere una rivoluzione nella sicurezza delle cure. Tredici anni dopo, è diventato l’emblema dell’inefficienza italiana: buone intenzioni tradotte in sistemi che non funzionano, burocrazia che prevale sul buon senso, sprechi che nessuno vuole affrontare.
Nel frattempo, i pazienti continuano ad essere curati “al buio”, con medici costretti a lavorare senza le informazioni che potrebbero salvare vite. E quando qualcosa va storto, nessuno sa bene di chi sia la colpa.
La tecnologia c’è. Gli investimenti ci sono stati. Manca solo una cosa: la volontà di mettere davvero al centro la sicurezza dei pazienti, anziché la copertura burocratica o il rispetto formale delle scadenze del PNRR.
A ottobre 2025, con l’ennesimo slittamento del PSS a dicembre, la domanda è: per quanto ancora i cittadini dovranno pagare il prezzo di un sistema che non funziona?