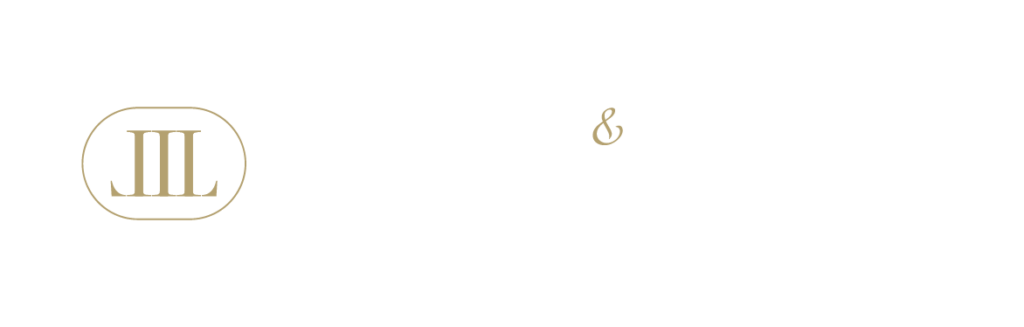Come funziona il risarcimento dei danni morali?
Immagina di aver subito un torto, magari a causa di un reato, e di voler chiedere un risarcimento per la sofferenza che hai provato. In questi casi, entra in gioco il “danno morale”, cioè il dolore interiore che deriva da un’azione ingiusta. Ma come si fa a dimostrare questo tipo di danno? E come fa il giudice a stabilire quanto denaro ti spetta?
Una recente decisione della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti importanti. Anche se un tribunale penale ha già riconosciuto che hai subito un danno, il giudice civile deve comunque esaminare attentamente la situazione. Deve capire se il danno morale esiste davvero e se è direttamente collegato all’evento che lo ha causato.
Per valutare il danno morale, il giudice può usare anche delle “prove presunte”. Questo significa che può basarsi su elementi come l’esperienza comune o il modo in cui le persone reagiscono in determinate situazioni. Ad esempio, se qualcuno viene minacciato, è logico presumere che provi paura e angoscia.
È importante sottolineare che il danno morale è diverso dal “danno biologico”, cioè dalle lesioni fisiche o psicologiche che possono essere accertate da un medico. Il danno morale riguarda invece le emozioni e i sentimenti, come la vergogna, la tristezza o la rabbia.
Infine, la legge stabilisce che il risarcimento per il danno morale deve essere proporzionato alla gravità del danno subito. Quindi, più grande è la sofferenza, maggiore sarà la somma di denaro che ti spetta.
L’analisi giuridica completa dell’Avv. Vincenzo Liguori è disponibile nel testo che segue:
Corte di Cassazione, Sez. 3, ord. n. 23586 del 28/7/2022
I principi di diritto ribaditi
La condanna generica in sede penale con rimessione al giudice civile per la liquidazione risarcitoria non esime quest’ultimo dall’accertamento dell’esistenza del danno e del relativo nesso causale tra lo stesso e l’evento lesivo.
Per quanto concerne l’accertamento e la quantificazione del danno morale, trattandosi di un danno attinente ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante, potendo costituire anche l’unica fonte di convincimento del giudice.
La vicenda
Il Trib. penale di Vibo Valentia e la Corte di appello penale di Catanzaro riconoscevano, rispettivamente in primo ed in secondo grado, la responsabilità degli imputati per i fatti loro addebitati in relazione ai reati di lesioni personali e di minaccia, condannandoli genericamente a risarcire i danni “anche morali” subiti dalle parti civili, da liquidarsi in separata sede e rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la determinazione del solo quantum debeatur.
Pur essendo stata dichiarata l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, le statuizioni relative ai danni da essi derivanti diventavano irrevocabili in virtù dell’intervenuto giudicato penale.
Radicatosi, a tale scopo, il giudizio civile, il giudice di prime cure (G.d.P. civile di Pizzo Calabro) accoglieva in toto la domanda risarcitoria dei danneggiati.
Tale decisione, tuttavia, trovava parziale riforma in appello (Trib. civile di Vibo Valentia), giacché, in tale sede, veniva esclusa l’esistenza della prova relativa al danno morale subito dalle vittime.
Avverso la pronuncia del giudice di seconde cure i danneggiati ricorrevano in cassazione sulla base di un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione, da parte del giudice civile di appello, degli artt. 2043, 2059, 2056, 1223, 1226, 2697, 2727 e 2729 c.c. in combinato disposto con gli artt. 115 e 278 c.p.c. e con l’art. 185 c.p. in relazione a due censure:
(-) La non necessità di accertare – come invece aveva ritenuto il Tribunale civile vibonese – l’an debeatur relativo al danno morale patito, in quanto il giudice penale avrebbe demandato al giudice civile la sola quantificazione sul punto e non l’accertamento della sua esistenza, invece rilevata in sede penale e passata in giudicato essendo divenuto irrevocabile “il capo della sentenza penale relativo all’accertamento di responsabilità per il danno”;
(-) L’errata omessa considerazione delle allegazioni difensive e delle risultanze probatorie comunque offerte dai danneggiati in sede civile, nel cui giudizio essi avevano comunque sufficientemente dedotto e provato il pregiudizio morale tramite fatti noti e presunzioni semplici, quali sufficienti elementi indiziari tali da ritenere presunta l’esistenza di tale danno, sicché “nessun ulteriore onere probatorio” poteva gravare sui ricorrenti-danneggiati.
Prima doglianza
La Suprema Corte ha ritenuto ovviamente non fondata la censura con cui i ricorrenti hanno assunto che il giudice penale, nel dichiarare la prescrizione del reato e nel disporre la condanna generica degli imputati al risarcimento del danno in favore delle parti civili, avrebbe demandato al giudice civile la sola quantificazione del danno e non, invece, l’accertamento della sua esistenza.
Difatti la pronuncia in esame ha ribadito il consolidato e risalente orientamento secondo cui:
(-) “la condanna generica al risarcimento del danno, contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera declaratoria iuris e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, indipendentemente dall’esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione” (Cass. Sez. 3, sent. 16 dicembre 2005, n. 2772:3, Rv. 587248-01, in senso conforme Cass. Sez. 1, sent. 19 aprile 2010, n. 9295, Rv. 612779-01)”;
(-) “nel caso di “sentenza del giudice penale che, accertando l’esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio”, non è esclusa “la necessità dell’accertamento, in sede civile, della esistenza” (e non solo “della entità”) “delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come «potenzialmente» dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (Cass. Sez. 3, sent. 27 agosto 2014, n. 18352, Rv. 632612-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 marzo 2018, n. 5660, Rv.648292-01)”.
Seconda doglianza
La Suprema Corte ha invece ritenuto fondata la censura con cui i ricorrenti hanno contestato l’affermazione del giudice di appello relativa all’impossibilità di applicare una “presunzione di sofferenza e paterna subito dalle vittime del reato” in quanto, così motivando, il Tribunale vibonese ha erroneamente escluso la possibilità di provare presuntivamente il danno morale.
Sul punto la S.C., con la decisione in esame, ha:
(-) dapprima evidenziato e ribadito l’oramai indiscussa autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico e agli altri danni che violano interessi costituzionalmente protetti in quanto esso è inerente al “vulnus di un diritto costituzionalmente protetto […] diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, del rapporto parentale”, (così, in particolare, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 17 gennaio 2018, n. 901, Rv. 647125-02)”;
(-) ribadito che la relativa prova può senz’altro raggiungersi sulla base del notorio, di massime di esperienza e di presunzioni.
Osservazioni
La S.C. ha condivisibilmente dato seguito al suo consolidato orientamento riguardo entrambe le questioni rappresentate dai ricorrenti.
- Poteri di accertamento del giudice civile nei c.d. reati di danno
Riguardo i poteri di accertamento del giudice civile e la necessità, per tale giudice, di accertare preliminarmente l’an della pretesa risarcitoria nell’ambito dei c.d. reati di danno, è oramai granitico l’orientamento espresso dalla S.C. secondo cui “Nel caso di sentenza penale che, accertando l’esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia anche condannato in via definitiva al risarcimento dei danni verso la parte civile, rinviando al giudizio civile la liquidazione degli stessi, in quella sede ha effetto vincolante, in relazione alla “declaratoria iuris”, di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell’accertamento, in sede civile, dell’esistenza e dell’entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati.” (Cass., sez. III Civile, ord. n. 8477 del 5/5/2020; cfr. anche Cass. civ. 9 marzo 2018, n. 5660; Cass. civ. 14 febbraio 2019, n. 4318).
Tale principio non è posto in dubbio da un’altra recente pronuncia della S.C. penale, la quale ha affermato che “L’azione civile assume carattere accessorio e subordinato rispetto all’azione penale, tanto da doverne subire le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, inserendosi all’interno del suo statuto. In questa cornice, la deviazione da tale paradigma nel caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di ultima istanza trova fondamento nella consumazione dell’accertamento circa la responsabilità penale dell’imputato, a seguito della quale il rinvio al giudice civile atterrà, esclusivamente, al profilo risarcitorio e restitutorio della vicenda.” (Cass., sez. III Penale, sentenza n. 14229 del 11/5/2020).
Infatti, laddove si afferma che l’esistenza del danno, nei c.d. reati di danno, è implicita nell’accertamento della commissione del fatto-reato, bisogna tener presente che il riferimento all’esistenza del danno (an debeatur) è inerente al mero danno-evento, il quale è correlato al fatto-reato da un nesso di causalità materiale, ma non anche al danno-conseguenza, rispetto al quale invece l’indagine va compiuta dal giudice civile in termini di nesso di causalità giuridica (cioè del nesso eziologico tra l’eventus damni e le sue conseguenze pregiudizievoli).
Nel giudizio civile instaurato al fine di ottenere il risarcimento del danno a seguito dell’intervenuto giudicato penale con cui siano stati irrevocabilmente dichiarati estinti i reati per prescrizione, dunque, se è indubbio che non possa essere rimessa in discussione l’esistenza del reato e la sua commissione – poiché elementi coperti da giudicato in relazione all’esistenza “implicita” dell’evento lesivo conseguente al reato – l’accertamento del giudice civile deve comunque riguardare il danno-conseguenza, secondo i normali canoni civilistici derivanti dall’art. 1223 c.c..
Dunque la pur intervenuta condanna generica in sede penale non esime affatto il giudice civile dall’accertamento del nesso causale, dell’an e del quantum relativi al danno-conseguenza, dovendosi ricondurre tale aspetto al normale onere di allegazione e prova gravante sulla parte danneggiata.
Va dunque inteso che, in coerenza con il vigente sistema risarcitorio – nel quale il danno è sempre danno-conseguenza e non è mai predicabile in re ipsa, cfr. ex multis Cass. n. 7385/2021 – il riparto dell’onere assertivo e probatorio deve seguire i già menzionati criteri fissati in materia civile, alla luce dei principi da tempo enunciati dalla S.C. (già da SS.UU. n. 13533/2001).
È chiaro che dovrà essere altresì la vittima ad allegare e dimostrare (quantomeno in via presuntiva) l’esistenza del pregiudizio morale-sofferenziale subìto in conseguenza del reato.
-
L’autonomia ontologica del danno morale
Da oramai quattro anni la S.C. ha sancito la “non più discutibile” (cit. contenuta in Cass. n. 23586/2022) ontologica autonomia del danno sofferenziale rispetto al danno biologico.
Infatti in materia risarcitoria, pur nell’unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, occorre distinguere, relativamente agli aspetti sofferenziali del danno:
(-) da un lato la “sofferenza psicofisica” (o sofferenza biologica, o sofferenza menomazione-correlata), che si riferisce a plurimi tipi di dolori comportanti effetti invalidanti apprezzabili dal punto di vista medico-legale e/o nosologico (così il “dolore nocicettivo”, il “dolore neuropatico”, il “dolore psichico”, il “dolore misto”, nel quale v’è la presenza di alcune o tutte le componenti precedenti);
(-)dall’altro la “sofferenza morale” (o patema d’animo o sofferenza interiore), categoria fenomenologicamente variegata e complessa, inclusiva di tutti i risvolti negativi dell’evento dannoso apprezzabili in relazione alla sfera del pathos, cioè la “sfera dell’intimo sentire” (ex multis Cass. n. 4712/2008).
In tale seconda categoria, per giurisprudenza costante e come pure sottolineato dagli ultimi approdi della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2464/2020, Cass. n. 28989/2019, Cass. 7513/2018), si pone l’aspetto interiore e più intimo del danno non patrimoniale, ossia la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, non avente base organica ed estranea alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente e/o temporanea.
È ius receptum, infatti, che per “sofferenza interiore” s’intenda per diritto vivente il “moto d’animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica prescindendo pertanto da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale” (Cass. n. 9865/2020).
Tra questi peculiari aspetti di sofferenza morale la S.C. ha sempre indicato, a titolo ovviamente esemplificativo e non esaustivo, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione, spaventi, angosce, timori e prove della vita, il rimorso, la malinconia, la tristezza, lo stress, i fastidi, le frustrazioni, le prostrazioni, i disagi, i dispiaceri, gli imbarazzi, i sentimenti di rabbia ed altre consimili emozioni negative.
La S.C., circa un ventennio fa, con una notissima coppia di sentenze gemelle ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. ed ha chiarito che “la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato della posto di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare la lacuna, secondo l’interpretazione ora superata della norma citata, nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale: quest’ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto” (Cass. 31/5/03 n. 8827; Cass. 31/5/03 n. 8828).
La Corte costituzionale, a sua volta, chiamata a decidere sulla conformità alla Carta fondamentale dell’art. 2059 c.c. sotto il profilo della legittimità della presunzione di colpa in ipotesi di astratta configurabilità di un fatto reato, a distanza di soli due mesi dal deposito delle suddette sentenze gemelle della S.C., in un motivato e significativo obiter dictum, ha affermato che “può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall’art. 2059 cod. civ., si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), che hanno l’indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni – nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori, inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona” (Corte cost. 11/7/03 n. 233).
Tale sinergico e pressoché sincronico intervento del giudice di legittimità e del giudice delle leggi ha dato vita, quindi, al sistema bipolare del danno alla persona che oggi conosciamo e, nella dimensione del danno non patrimoniale, ad una vera e propria tripartizione, dotata di pari dignità categoriale e costituita dal danno biologico, dal danno morale e dal danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Le corti di merito, in questa realtà legislativa e giurisprudenziale, hanno costantemente liquidato separatamente il danno morale in una frazione (nella misura oscillante tra un terzo e la metà) del danno biologico (v. le tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano in uso).
Anche lo stesso Osservatorio del Tribunale di Milano, successivamente e dopo il deposito delle famose sentenze gemelle di San Martino (Sez. Un. 11/11/08 n. 26972 e succ. conformi):
(-) “ha rilevato l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l’inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale”;
(-) ha proposto, pertanto, “la liquidazione congiunta:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
- e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva“, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:
- c.d. danno biologico “standard”
- c.d. personalizzazione -per particolari condizioni soggettive- del danno biologico
- c.d. danno morale” (v. prefazione alle tabelle 2009 del Tribunale di Milano).
L’autonomia del danno da sofferenza rispetto al danno dinamico-relazionale è stata ulteriormente sancita dalla S.C. a decorrere dal 2018 (cfr. ex multis Cass. n. 901/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 2788/2019) e pure consacrata con le più recenti decisioni “San Martino 2019” (Cass. n. 28985/2019, Cass. n. 28986/2019, Cass. n. 28989/19), nonchè già da Cass. n. 2788/2019 (Travaglino-Porreca, nella quale viene ampiamente affrontato anche il tema della personalizzazione del danno dinamico-relazionale).
La più recente giurisprudenza della S.C., pertanto, in coerenza con le basi gettate circa un ventennio fa, afferma che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in peius” con la vita quotidiana del danneggiato (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, purchè provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr. Cass. 7/3/2022 n. 7395, Cass. n. 4878/2019, Cass. n. 901/2018, Cass. n. 23469/2018).
Non è in discussione il principio, ormai consolidato, del bipolarismo risarcitorio, che vede “accomunate” sotto l’ègida del danno non patrimoniale le diverse voci di danno afferenti gli aspetti a-reddituali del soggetto leso (cioè non aventi diretta rilevanza economica sulla vita del danneggiato).
Tuttavia non è da porre parimenti in discussione l’autonoma apprezzabilità del contenuto e dei distinti pregiudizi concretamente riconoscibili all’interno della macro-categoria del danno non patrimoniale.
Dunque, proprio in quanto la macro-area “danno non patrimoniale” funge da contenitore dei distinti ed ontologicamente diversi pregiudizi non-economici subiti dalla vittima, tali distinte voci di danno devono pur essere individuate ed apprezzate in concreto in relazione alle peculiari irripetibilità del caso concreto, comprendendo dunque tanto quelle di natura morale (sofferenze fisiche o psichiche), tanto quelle biologiche (lesione del bene salute) quanto quelle c.d. esistenziali (alterazione in peius della qualità della vita, degli aspetti dinamico-relazionali e dell’agenda quotidiana della vittima, costretta ad un fare e/o ad un non-fare che avrebbe evitato in mancanza del fatto illecito altrui).
Nell’ambito della liquidazione pur unitaria del danno non patrimoniale ed in presenza di specifiche allegazioni e prove relative a tali distinti aspetti di danno (come assunto nel caso oggetto della pronuncia in esame), il giudice deve sempre specificatamente indicare, sia pure nell’ambito della liquidazione unitaria, di quali pregiudizi subiti dalla vittima abbia tenuto conto, motivando con una liquidazione separata tali voci di danno ritualmente addotte, motivate e richieste, anche al fine di consentire alle parti la valutazione della liquidazione ai fini dell’eventuale censura tramite proposizione di gravame.
Tale esigenza discende dalla necessità di modulare il risarcimento in base ai concreti pregiudizi subiti dalla vittima, senza pericoli di duplicazioni risarcitorie – spesso “temute” a causa dell’imprinting dogmatico afferente la necessità di “liquidazione unitaria” del danno non patrimoniale – ma allo stesso tempo senza lasciare sforniti di tutela risarcitoria pregiudizi in concreto subiti dal soggetto leso.
Si tratta, in sostanza, di poter distinguere il pregiudizio morale dal danno biologico, quali danni ontologicamente diversi.
Solo aderendo a tale prospettiva si concretizza l’effettiva realizzazione del principio, affermato anche dalle stesse sentenze di San Martino (sia quelle del 2008 che quelle del 2019), dell’integrale risarcimento del danno alla persona, di valenza internazionale e comunitaria, che non può in alcun modo soffrire limitazioni risarcitorie.
-
La prova presuntiva del danno morale
Pur rendendosi necessaria una “rigorosa valutazione, sul piano della prova, […] dell’aspetto interiore del danno” (Cass. n. 901/2018), questa prova può senz’altro raggiungersi sulla base del notorio, di massime di esperienza e di presunzioni (Cass. n. 23586/2022, Cass. n. 2788/2019, , Cass. n. 901/2018, Cass. Sez. Un. civ., 11/11/2008, n. 26972).
Tale rilievo, peraltro, si pone in linea con quanto statuito dalle SS.UU. di San Martino 2008 in ordine al ricorso alle presunzioni per la dimostrazione dei pregiudizi non patrimoniali non accertabili a livello medico-legale.
È ius receptum, infatti, che:
(-) “attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri” (Cass. Sez. Un. civ., 11/11/2008, n. 26972; cfr. Cass. n. 23586/2022, Cass. 28989/2019, Cass. 7513/2018, Cass. n. 6387/2018, Cass. 910/2018);
(-) costituendo un mezzo di prova di rango non inferiore agli altri, in quanto di grado non subordinato nella gerarchia dei mezzi di prova e dunque non “più debole” della prova diretta o rappresentativa, ben possono le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice (cfr. Sez. Un. n. 26972/2008; Sez. Un. n. 6572/2006, Cass. n. 13546/2006, Cass. n. 9834/2002), costituendo una “prova completa” (cfr. Cass. n. 13546/2006, Cass. n. 2643/1968).
-
Quantificazione “presuntiva” del danno morale
Anche in relazione alla quantificazione, nella prassi processuale ed anche secondo le tabelle elaborate tramite il sistema del punto variabile, il danno morale si presume sempre correlato per entità, in via proporzionalmente crescente ed anche in assenza di un rigoroso accertamento, all’entità del danno biologico.
Ciò risulta necessario sia perché non è agevole provare l’intensità del dolore se non tramite presunzioni e sia perché non è di norma sostenibile, secondo l’id quod plerumque accidit, che da una lesione dell’integrità psico-fisica dell’individuo non derivi anche una “normale” e proporzionalmente correlata sensazione di dolore, e quindi un danno morale (cfr. in dottrina M. Rossetti, Il danno da lesione della salute, Padova, 2001, 1114).
Questa ineccepibile impostazione dottrinale che avalla il riconoscimento in via presuntiva di una quota di base del danno morale da lesione personale – stabilita ed allocata in via presuntiva e proporzionale rispetto al danno nella sua componente biologica – trova conferma anche a livello normativo.
Infatti tale tesi ha trovato nel tempo indiscutibile supporto:
(-) nella nuova formulazione dell’art. 138 D.Lgs. 209/2005 (come modificato dall’art. 1, comma 17, L. 124/2017), il quale discorre espressamente, al nuovo comma 2, lett. e), che ai fini della redazione delle tabelle monetarie per le invalidità permanenti da 10% a 100% il criterio di elaborazione della tabella debba consentire “di considerare la componente del danno morale da lesione dell’integrità fisica”;
(-) anche nel già noto D.P.R. 3/3/2009, n. 37 (Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, ex art. 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), che, all’art. 5, comma 1, lett. b) e c), rubricato “Criteri per la determinazione dell’invalidità permanente”, mantiene salda la distinzione tra danno biologico e danno morale ed altresì – “positivizzando” questa categoria con la “sofferenza” ed il “turbamento dello stato d’animo”, oltre che con la “lesione alla dignità della persona” – assume il criterio della parametrazione presuntiva/proporzionale del danno morale rapportata all’entità del danno biologico “in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico”.
È ius receptum, infatti, che “i parametri medico-legali che vengono utilizzati per determinare il quantum del danno biologico – sia in riferimento alle conseguenze temporanee della lesione psico-fisica, sia in riferimento alle conseguenze permanenti – non possono non incidere anche sul quantum del danno “morale” nel senso di sofferenza direttamente correlata alla lesione psico-fisica della stessa persona, pur trattandosi formalmente, a ben guardare, di un pregiudizio ontologicamente diverso” (Cass. n. 29495/2019).